«Vuoi la felicità? Sposati»
Perché ha ancora senso pronunciare il ‘sì’ allʼaltare?
«Dio si è fidato abbastanza degli uomini da fargli amministrare il sacramento»
L’amore per sempre può esistere davvero. Lo racconta con ironia una scrittrice, nonché moglie e mamma Ecco perché nell’epoca del crollo dei matrimoni si può tornare a investire in un progetto ‘ senza data di scadenza’.
Dal libro di Anna Porchetti “Amatevi finché morte non vi separi. Il matrimonio: scelta per uomini coraggiosi e donne veramente libere” (Effatà Editrice, pagg.142, euro 14) – è tratto lo stralcio di questa pagina.
Si rivolge a un’amica immaginaria, probabilmente una delle tante ragazze un po’ cresciute che sul limitare tra giovinezza e maturità, confine oggi sempre più evanescente, continua a rimandare la scelta più importante della vita, sfogliando una margherita che sembra avere petali infiniti: ‘Mi sposo o non mi sposo?’. La posizione dell’autrice è chiara. Nessuna esitazione. Certo, occorre scegliere l’uomo giusto, navigando in una palude di procrastinatori, ‘medioman’ e presunti principi azzurri. Ma attendere a tempo indeterminato, aspettando l’uomo perfetto, è inutile. Nessuna la troverà mai perché non esiste, come non esiste la donna perfetta. Porchetti argomenta tutto con il sorriso sulle labbra. E non è l’unico valore aggiunto di questo volumetto tutt’altro che scontato.

Ha ancora senso sposarsi? In un mondo in cui ci sono più divorzi che nuovi matrimoni, in cui tanti, addirittura, fanno ancora prima ed evitano di sposarsi, magari convivono, oppure tu a casa tua e io a casa mia, ci vediamo ogni tanto se non ho la partita di calcetto o la réunion con gli amici delle medie o la lezione serale di yoga, chiedersi se sia sensato o no sposarsi capita sempre più spesso a tanti. Anche a gente al di sopra di ogni sospetto.
Anche all’amica che ha disegnato il suo abito da sposa quando era ancora al liceo e non aveva nemmeno il fidanzato. Anche all’altra amica, quella che sogna di fare la mamma da quando ha avuto il primo Cicciobello, a sei anni: correva l’anno 1978, nello scorso millennio. Persino fan più sfegatate del matrimonio, le donne romantiche, quelle tradizionaliste, vedono incrinarsi quella che per secoli è stata una delle nostre grandi certezze: che il coronamento dell’amore fosse il matrimonio, che senza di esso non potesse esserci nessun lieto fine.
Degli uomini non saprei dire. Non ho idea di quando si affacci nella mente di un uomo l’idea concreta che si sposerà. Sospetto che sia quando si innamora davvero. È un dato di fatto che, a un certo punto della loro vita adulta, anche gli uomini comincino a pensare al matrimonio. Per lo meno un tempo. Adesso la scelta è opzionale, conosco tanti che dicono: «Forse mi sposo ma forse anche no, forse la prossima primavera, l’anno che viene, in fondo, che fretta c’ è? Potrò sempre decidere di sposarmi più avanti». Anche io potrò sempre decidermi a ripulire la cantina.
Come no. In fondo sono solo due decenni che includo l’attività nei buoni propositi per l’anno nuovo e almeno il seggiolino bimbo per l’auto forse potrei darlo via, ora che l’ultima figlia ha quindici anni.
Sul senso del matrimonio, si interrogano in tanti: il matrimonio è morto? Il matrimonio è vecchio? Il matrimonio ha ancora valore? Il matrimonio ha perso di significato? (…).
La mia teoria è che, con un buon matrimonio, tu possa essere felice senza nessuna di queste cose… e senza molte altre. Un bel risparmio, a conti fatti. La condizione per accedere a questa felicità profondissima, ma a low profile, sta nel prendere sul serio una frase che avrai già sentito milioni di volte. Non è: «Be inspired», «Connecting People», «Just do it». Non è: «Taste the feeling» come dice la Coca-Cola. Nemmeno «I am loving it», come dice McDonald’s, tutti slogan che la gente normale, che fa la coda in posta e prende l’autobus, non ha idea di cosa vogliano dire. Comunque, no, la frase a cui mi riferisco non è nessuna di queste. È: «Amatevi finché morte non vi separi». Che vuol dire: sposati sapendo di rinunciare alla clausola di recesso. Sposati sapendo che il marito non si può restituire dopo sette giorni. Ma nemmeno dopo sette mesi o sette anni. Perché il matrimonio è indissolubile. Quindi il marito te lo devi tenere. C’è di più. Il fatto che al matrimonio non si applichi la clausola “soddisfatti o rimborsati” rende inutile ogni periodo di osservazione o di prova. Vuol dire che voi due dovete essere soddisfatti per forza, il che è possibile, credimi. E ti rivelerò anche come, a patto che tu rimanga incollata alla lettura delle prossime due o tremila righe: già ti sto rivelando tutto il mio know how, mica pretenderai pure il dono della sintesi? (…).
D’accordo, in molti sostengono che farsi una famiglia non sempre dia la felicità. Forse è anche vero. Non ci credo, ma potrei anche sbagliarmi. Il matrimonio magari non darà sempre la felicità, ma non mi sembra che la solitudine, invece, colmi la gente di gioia fino a traboccarne. Può darsi che esistano single che conducono un’esistenza scoppiettante, gente che trasuda felicità da tutti i pori, anziché sebo, come noi comuni mortali. Può anche darsi che esistano gli Ufo, mica possiamo escluderlo a priori, anche se nessuno li ha mai visti davvero. E può anche darsi che, alla fine, questo matrimonio così demonizzato, questa istituzione così obsoleta e polverosa, questa idea dell’amore romantico che sopravvive agli anni e ai dissesti fisici, anch’essa esista davvero. Nel dubbio, scegli la felicità. Credici. Sposati.
su: Avvenire 9 ottobre 2022







 SONO MARCO EVANGELISTI,
SONO MARCO EVANGELISTI,

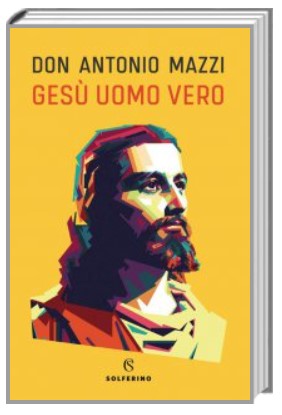



 «La libertà sessuale dei ragazzi. Com’è difficile trovare le parole per parlarne»
«La libertà sessuale dei ragazzi. Com’è difficile trovare le parole per parlarne» 








